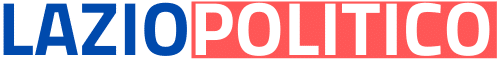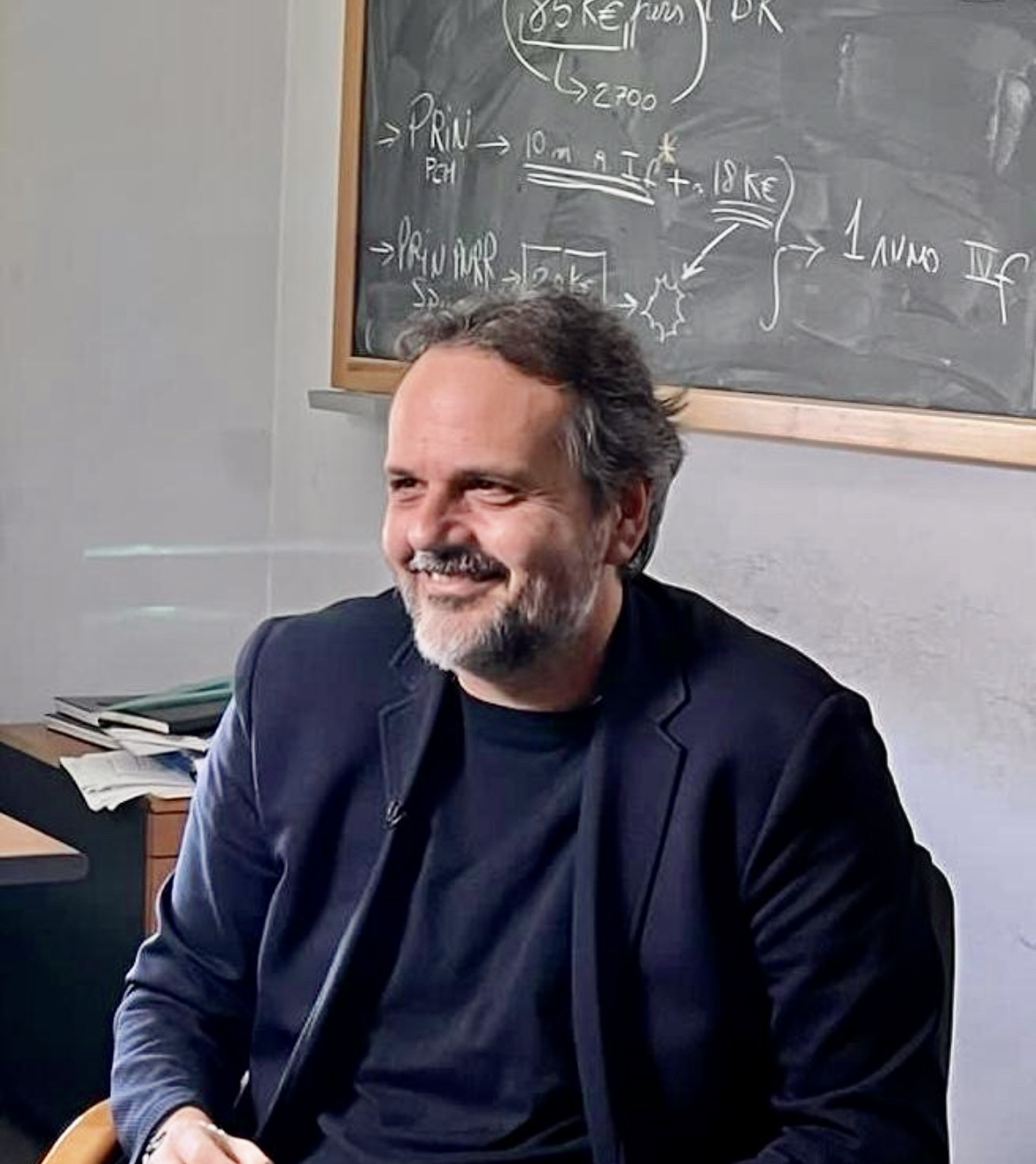COP30, Belém — Dieci anni dopo Parigi: clima, leadership e il coraggio della democrazia adulta
È sempre più difficile entrare in un’aula universitaria, presentare dati veri, misurabili e verificabili, e poi osservare come la politica e l’economia reagiscano al cambiamento climatico con un linguaggio che si allontana dalla realtà.
A Belém oltre 50.000 delegati cercano una direzione; ma lo scenario è diverso da quello del 2015: la geopolitica ha scalzato l’ambiente dall’agenda delle priorità e l’Europa stessa sta rivedendo il suo Green Deal, non per negare la transizione, ma perché i costi sono diventati difficili da sostenere senza una base produttiva e sociale adeguata.
È qui che si vede la fragilità della leadership contemporanea: una parte significativa della politica preferisce attenuare gli obiettivi, rallentare la traiettoria, cercare consenso promettendo che “alla fine torneremo come prima”.
Ma la verità, quella che i dati impongono, è un’altra: il mondo come lo conoscevamo non tornerà più.
Il clima non può essere “ripristinato”; può essere solo governato.
La contraddizione globale è ancora più evidente se guardiamo alla Cina: leader assoluta nelle tecnologie verdi — pannelli solari, eolico, batterie — e allo stesso tempo primo emettitore di gas serra per via dell’enorme dipendenza dal carbone. La transizione mondiale si regge su un sistema produttivo che, per funzionare, consuma ciò che dovrebbe superare.
Questa è la complessità del presente, non un suo difetto: è la condizione in cui dobbiamo imparare a muoverci.
E qui entra in gioco la questione democratica, non come cornice etica, ma come condizione tecnica della transizione.
Tutte le strategie climatiche — mitigazione, adattamento, cooperazione internazionale — sono necessarie e giuste. Ma possono essere efficaci solo se si fondano su un presupposto onesto: non stiamo agendo per restaurare un equilibrio perduto, ma per costruirne uno nuovo, dentro un mondo che è già cambiato.
La responsabilità politica oggi è questa: non promettere la cancellazione della crisi, ma governarla.
Ridisegnare istituzioni, economia, modelli energetici e perfino la nostra idea di vita collettiva.
Una leadership adulta non sceglie tra speranza e realtà: le tiene insieme.
Sa che la speranza non nasce dalla negazione della crisi, ma dall’azione dentro la crisi.
Sa che riconoscere la perdita — ambientale, economica, psicologica — non è resa, ma la condizione per orientare lo sforzo collettivo verso ciò che può ancora essere costruito.
Il limite della democrazia contemporanea è che il consenso, quasi sempre, si ottiene promettendo “qualcosa in più”, non “qualcosa di diverso”. E ciò che è diverso genera paura, perché costringe a immaginare scenari nuovi e poco rassicuranti.
Ma guidare un’epoca di cambiamenti strutturali significa proprio questo:abitarli, non negarli.
E lavorare perché il mondo che inevitabilmente emergerà sia il più umano, equo, vivibile e possibile.
Luca Andreassi, Professore presso la Facoltà di Ingegneria Università di Roma Tor Vergata